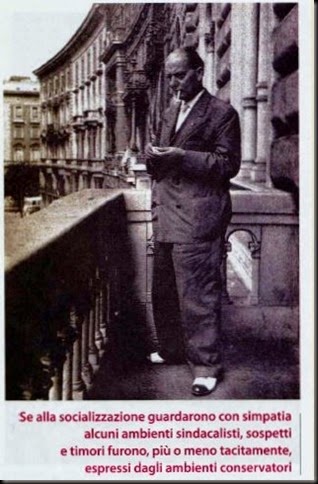di Carlo Francesco D’Agostino
La ostentata esaltazione che certa stampa ha fatto della figura dell’on. Degasperi come preteso statista cattolico, ci obbliga a ristabilire la verità, con precise e documentate contestazioni. Con questo non intendiamo indagare se e quanto Degasperi sia stato in buona fede, nella sua maschera – poiché tale e non altro era – di uomo politico cristiano: non usiamo mai affermare la buona o la mala fede di alcuno. Possiamo solo, e lo facciamo ben volentieri, riconoscere che grandissima parte di coloro che hanno appoggiato l’azione politica del Degasperi e del suo Partito sono stati presumibilmente in buona fede. Noi abbiamo sempre criticato, su questo giornale [“L’Alleanza Italiana”] e su altre pubblicazioni, alcune delle quali di una certa mole, l’opera del defunto capo della Democrazia Cristiana. Ci limitiamo dunque, per documentarla realtà agli ormai numerosi lettori, a riassumere i motivi principali delle passate nostre critiche.
Lo faremo con una certa schematicità cronologica, e con concisi commenti che servano ad illuminare quale sola poteva e può essere una posizione politica basata sul Cattolicesimo.
Fu prima solidale con il Fascismo
1922: Degasperi alla Camera diede, a nome di oltre cento Deputati del Partito Popolare Italiano, pieno appoggio al Governo Fascista (di cui faceva parte anche l’on. Gronchi con altri Deputati del P.P.I.). Egli gli riconobbe: «volontà fattiva di governo ed il proposito e la forza di ristabilire la legge e la disciplina nel Paese… scopo che va assolutamente raggiunto se la boccheggiante Nazione deve essere salva»: questo disse dopo che Mussolini aveva ben precisato essere suo intendimento: «difendere e potenziare al massimo grado la rivoluzione delle Camicie Nere, inserendola intimamente come forza di sviluppo, di progresso e di equilibrio nella storia della Nazione» (Atti del Parlamento, vol. IX, 1922, pag. 8390 ss.). Al lume dei principî cristiani era ben chiaro che un regime arrivato al potere con una serie di violenze delittuose, e che la sua impostazione confermava con l’arroganza del discorso presidenziale tenuto da Mussolini, non poteva presentare garanzie di sorta. Quel regime tendeva, in sostanza, a rinsaldare le posizioni dell’egemonia capitalistica di fronte al rivoluzionarismo socialistoide, da un lato, ed alla inefficienza degli uomini che, col Degasperi, avrebbero dovuto rappresentare la scuola politica Cattolica. Degasperi, accodando i Cattolici alla duplice sopraffazione, capitalistica e fascista, pose le chiare premesse di tutto il nefasto seguito della sua opera politica.
Sull’Aventino poi si pose contro la legalità
1924-25: Degasperi ed i Deputati del P.P.I. in significativa unione con i social comunisti abbandonarono il Parlamento, tentando di impostare una «questione morale» sul delitto Matteotti. Questo non era stato che uno dei tanti episodi di violenza dell’illegalismo fascista, che dal Degasperi aveva avuto il premio del voto favorevole al Governo Fascista ed all’amnistia.
Dopo aver vantato, nel 1922: «liberi da ogni viltà – oggi, come ieri, come domani – per la sollecitudine delle nostre persone che sono poca cosa, forti dell’assenso che ci viene da chi liberamente ci diede il mandato, lo eserciteremo con serenità ed equilibrio, con la sola preoccupazione dei supremi interessi del paese» (loc. cit., pag. 8143). Degasperi ed i suoi compirono la viltà di astenersi dal loro dovere di parlamentari, con l’aggravante di non rinunciare al mandato, ed ordirono quella campagna di stampa sul delitto Matteotti che ebbe il chiaro carattere di un tentativo di violenza morale, sul terreno extraparlamentare, per vincere una battaglia politica condotta e perduta sull’unico terreno legittimo, quello parlamentare. Essi ricorsero ad un metodo strettamente anticostituzionale, tentando di ottenere da Sua Maestà il Re lo scioglimento della Camera appena eletta ed in cui si rifiutavano di combattere (ciò che invece continuò a fare l’on. Giolitti con pochi altri Deputati demoliberali). E questo mentre era in corso l’inchiesta giudiziaria, e mentre le responsabilità in ordine al delitto Matteotti non erano ancora chiarite. Uomini come Filippo Meda, Cavazzoni, Martire, Mattei Gentili, Carapelle ed altri, non vollero condividere la faziosità aventinistica del Degasperi, il quale poi, dopo il 1945, quando era universalmente riconosciuto esser stato un errore l’abbandono del Parlamento, ebbe ancora la temerarietà di qualificare «roccaforte della libertà» quell’aventinismo che aveva invece rappresentato l’abbandono della difesa della libertà stessa!
Ordì una rivolta anticristiana
1942: fallitogli il tentativo di espatriare ed estraniatosi, nei momenti più ardui, dal servizio del Paese, Degasperi rimase agganciato a quel Comitato Centrale Fascista che rappresentò una organizzazione illegale ed immorale, intima unione di massoni, marxisti, materialisti, atei, settari e …democristiani, e che fu strumento tremendamente nefasto per sollevare l’opinione pubblica mondiale contro l’Italia cattolica, col pretesto del Fascismo. Degasperi ha confessato: «La Liberazione dal fascismo appariva ancora molto remota, e nessun partito, vecchio o nuovo, si era ancora costituito, quando nel Comitato Centrale Antifascista sorse l’idea di chiamarsi Democrazie Unite: democrazia liberale, democrazia socialista e…che cosa potevamo essere noi se non la democrazia cristiana?» (ved. Tradizione ed ideologia della D.C., ed. 1944 e ristampe, presso la D.C., Roma). Con questo dimostrava la mancanza di un pensiero Cristiano, il quale non si qualifica certo come una sottospecie dell’utopia democratica, condannata dalla Chiesa, che per di più per bocca di Leone XIII, nella Graves de communi, ha ingiunto: «non sia poi lecito dare un senso politico alla Democrazia Cristiana»!!
Fattone, invece, proprio un Partito, il Degasperi, con l’animo pieno di «legittimo orgoglio» – come scrisse – mettendosi tra «coloro che erano passati attraverso il lungo periodo senza inflessioni e senza contaminazioni »…«ora che la vittoria contro il Fascismo appariva probabile» (e questa «vittoria» era la catastrofe politico-militare e morale della Patria!) partecipò alla firma del Patto da cui sorse il Comitato di Liberazione Nazionale. Ivanoe Bonomi, che lo promosse, così si esprime (Diario di un anno, ed. Garzanti): «L’antifascismo (era) un movimento sotterraneo a cui il declino militare dell’Asse dette nuovo vigore». Esso, a dire del Bonomi: «già da anni minava lo Stato totalitario e sentì che si avvicinava la sua ora e che era urgente stringere i contatti e cominciare l’azione. I tempi stringevano ed occorreva precisare le intese con convegni cui partecipò ugualmente fervido ed operoso Alcide Degasperi». Ebbene, prosegue Bonomi: «Fu in quelle riunioni che si tracciò un piano d’intesa, tradotto poi in un patto scritto, firmato da me, dal Casati, dal Ruini, dal Degasperi, dal Romita e anche da un comunista di nome oscuro ma interprete autorizzato dalla sua corrente. Quel patto impegnava i partiti ad una tregua politica nell’ora del trapasso e nel periodo successivo della ricostruzione, indicando come meta comune un regime democratico nel quale «tutti i poteri, e anche il più alto, derivassero dalla volontà popolare». La stampa filodemocristiana, anche quella che pretende avere carattere ufficiale «cattolico»,si è ben guardata dal mettere in luce questa sostanza vergognosa di tutta l’opera del Degasperi e del suo gruppo di dittatori del Partito Democristiano.
Noi lo facemmo invece innumerevoli volte su questo giornale [“L’Alleanza Italiana”] – dagli esordi clandestini del 1944 – e nel volume «La illusione democristiana » scritto nel 1949, oltre che in precedenti pubblicazioni. Il «patto» firmato dal Degasperi era un patto di rivoluzione, impostato su principî mille volte solennemente condannati dalla Chiesa oltreché dalla ragione umana: ed era un patto che legalizzava e potenziava i Partiti più notoriamente anticattolici – dal comunista al Liberale – impegnando le forze cristiane ad una lunga tregua nei loro confronti fino a quando non si fosse realizzato un ideale anticristiano, quale è quello della rivoluzione demoliberale!
Quale prova più evidente della mancanza assoluta di direttiva Cristiana nell’opera del Degasperi e del tragicissimo inganno da lui teso a quelli, per primi, che ignari di tutto questo hanno accettato la D.C. come il «partito dei Cattolici»?.
Firmò leggi che comportano la Scomunica
1946-47-53: perfettamente coerente alla impostazione demo liberale e laicista della Politica, Degasperi firma le varie Leggi elettorali (fatte e rifatte alla vigilia di ogni elezione per tentare di assicurar meglio il predominio democristiano), in cui è quell’art. 66, poi 71, che pone i limiti al Clero che «abusando della proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione», istituendo per tali ipotesi un reato, con gravi pene. Il Santo Padre, nel discorso ai Quaresimalisti di Roma del 17 marzo 1946 palesemente protestò per tale violazione della libertà della Chiesa inferta dal Governo democristiano: «Il sacerdote cattolico – disse il Papa – non può essere semplicemente equiparato ai pubblici ufficiali o agli investiti di un pubblico potere o funzione civile o militare»; la legge elettorale, infatti, con una medesima norma colpiva tali categorie ed il Clero: «Il Sacerdote è ministro della Chiesa ed ha una missione che si estende a tutta la cerchia dei doveri religiosi e morali dei fedeli…e può quindi essere obbligato a dare, sotto quell’aspetto, consigli o istruzioni riguardanti anche la vita pubblica.
Ora è evidente che gli eventuali abusi di tale missione non possono per sé essere lasciati al giudizio dei poteri civili…».
Degasperi accusò il colpo, e nel discorso di Torino del 25 marzo 1946 replicò ampiamente, e concluse col comodo ed ipocrita ripiego: «…so che se il Santo Padre ha in nome della Chiesa il diritto di stabilire le sue tesi ed Egli ha questo diritto per ragione che supera i partiti ed i momenti…saprà anche comprendere le difficoltà in cui gli uomini cattolici si battono e vincono e possono vincere solo fino ad un certo punto.
È rimasta una piccola pizzicatura per il Clero. Ma credo che i sacerdoti non ne abbiano molta paura» (Il Popolo, 26-3-1946). Comodo ripiego, perché significava ammettere in partenza che le norme della Chiesa (nella specie sanzionate perfino nel Codice di Diritto Canonico), che al canone 1334 commina la scomunica automatica contro coloro che varano leggi che offendono la libertà ed i diritti della Chiesa) varrebbero solo nei limiti in cui i «fedeli» hanno voglia di combattere per rispettarle. Ipocrita ripiego, perché invece il Degasperi fin dal 1944, combattendo contro il Centro Politico Italiano con l’opuscolo più sopra citato, si proclamava difensore della concezione dello «Stato moderno» assertore di una assoluta «uguaglianza giuridica» e lo faceva espressamente contro l’esigenza da noi posta di una impostazione Cristiana dello Stato.
Non era dunque questione che gli uomini politici Cattolici possano combattere e vincere «solo fino ad un certo punto»: a parte che si è sempre saputo che il Cattolico, piuttosto che piegarsi a compromessi, resiste fino a cadere sotto i colpi del martirio, consapevole che il sangue dei Martiri è semenza di Cristiani, a parte questo stava in fatto che il Degasperi volendo servire la cosiddetta concezione «moderna» dello Stato, non era un combattente per il Cristianesimo, ma un alfiere dell’anticristianesimo, per la cui realizzazione politica si era impegnato ad unità d’azione coi più classici nemici del nome Cristiano.
Rese ateo lo Stato Italiano
1947: alla Costituente il Gruppo democristiano respinse la proposta dell’on. Lucifero di iniziare il testo della Costituzione con le parole: «Il Popolo Italiano, invocando l’assistenza di DIO, nel libero esercizio della propria sovranità… »: così la Costituzione rinnegò la sacra autorità di DIO; respinse la proposta dell’on. Patricolo, che un articolo precisasse: «La Religione Cattolica è la Religione ufficiale dello Stato Italiano» e così il nostro Stato rigettò ogni impostazione Cristiana; Degasperi sanzionò il tutto ricordando le assicurazioni da lui date «ai protestanti d’America» circa una «piena libertà, piena uguaglianza» che la Costituzione democristiana infatti accorda al Protestantesimo, cui ha concesso perfino l’uso della Radio per le trasmissioni di culto (pag. 2456 Atti della Costituente). Ed in realtà è libero e protetto in Italia ogni altro culto, e vi si diffondono. Così la concezione dello «Stato moderno» da Degasperi tenacemente perseguita era realizzata nella Legge fondamentale della Repubblica, e le conseguenze tutti le tocchiamo con mano.
Lo sbandieramento di un Cristianesimo soltanto ipocrita doveva portarci rapidamente nel doloroso clima del putridume di «Capocotta» e della apologia dei traviamenti di Coppi fatta su quotidiani di proprietà di uomini della Democrazia Cristiana (ved. Voce della giustizia, n. 36 del 4-9-1954)! Una politica tutta legata all’affarismo e che, in nome di questo, chiude gli occhi ad ogni esigenza Morale: un rinunciatarismo impressionante che dopo aver elargito una Costituzione secondo il gusto del Protestantesimo anglosassone premia solennemente registi, come il Rossellini, la cui scandalosa condotta di profanatore del sacro tempio della unità famigliare aveva riempito le cronache di una stampa lasciata libera di corrompere, per cui si stan creando tutte le premesse per la introduzione del divorzio in Italia, già largamente reso possibile da tristi accomodamenti dei nostri Trattati internazionali e della nostra giurisprudenza.
L’abominio di un malgoverno
Questa, in sintesi, è stata l’opera di Degasperi. Dinanzi a tanti frutti di distruzione morale par quasi secondario ricordare le ingiustizie perpetrate con la legislazione di persecuzione contro gli ex fascisti; le immoralità compiute con le leggi di espropriazione terriera, fraudolentemente denominate «riforma agraria»; la distruzione progressiva del patrimonio immobiliare urbano come conseguenza del delittuoso regime delle locazioni; il danno recato all’agricoltura e le profonde violazioni di giustizia, conseguenti alla legislazione sui contratti agrari; il disordine e la somma di ingiustizie e sperequazioni, oltreché di corruzione, immensamente aggravatosi nel sistema tributario, in cui la legislazione degasperiana ha di gran lunga peggiorato i malanni da tempo esistenti; la mancata difesa del patrimonio boschivo, col conseguente continuo accrescersi dei disastri che produce; l’aggravamento della situazione nel campo della cultura con un regime scolastico, ora poi affidato ad un Ministro liberale, che, in uno al regime di stampa, sta riducendo la intellettualità italiana al bassissimo livello che ogni giorno paurosamente constatiamo.
Il rigetto dei principi del Toniolo
Tutto questo era e doveva essere il frutto dell’abbandono delle posizioni cui la scuola del Toniolo aveva tenuto ancorati – sulla scia degli Insegnamenti dei Papi – i Cattolici italiani. Degasperi, in quella che viene considerata la sua ultima lettera, e quasi un testamento spirituale (lettera a Fanfani del 9 agosto 1954, ved. co di Bergamo, n. 200), ha lasciato scritto: «Perché il Toniolo, nazionalmente parlando, ebbe efficacia così inadeguata? Perché i tempi e gli uomini non gli permisero di sfuggire alla alternativa guelfa – ghibellina, e così non uscì dallo storico steccato politico, benché ne fosse uscito da quello sociale. Il nostro sforzo più tardi, fu quello di sfuggire alla stretta. Non siamo riusciti spesso, ma ad un certo punto la D.C. divenne un movimento, un partito italiano, al disopra dello storico conflitto. Teniamolo a mente: non bisogna lasciarsi avvinghiare dalle spire dell’alternativa tradizionale». Fino all’ultimo, dunque, Degasperi ha giuocato all’ inganno, e speriamo che non se ne sia reso pieno conto. Giuseppe Toniolo non rimase affatto ancorato ad una «superata» alternativa. Egli semplicemente non volle piegarsi a quella concezione dello Stato che definì «disordine legale permanente delle democrazie cosiddette liberali». (Toniolo, Concetto Cristiano di democrazia, ed. Coletti). Degasperi mostra di bellamente dimenticare questa profonda differenza tra l’indirizzo del Toniolo ed il suo. Ha dimenticato di aver scritto, come abbiamo ricordato, in polemica col Centro Politico Italiano: «Bisogna respingere qualsiasi tentazione di leggi eccezionali, di provvedimenti che escludano dal diritto comune o precludano da certe pubbliche funzioni chi sia alieno dal tradizionale spirito cattolico del Popolo Italiano. Nello Stato moderno l’uguaglianza giuridica e la ammissibilità agli impieghi è divenuta ormai una premessa indispensabile alla libera convivenza civile» (loc. cit.). Pertanto lo Stato democristiano deve lasciar aperto l’adito ai professori materialisti sulle cattedre di Filosofia, ai docenti liberali su quelle di Diritto, agli atei su quelle di Storia del Cristianesimo o delle religioni. Così di seguito. Non solo il Toniolo, ma il Papa e la Chiesa non si piegano a questo, come non ci si può piegare ogni cultore di filosofia naturale. Tardò solo di un anno, infatti, la risposta del Santo Padre: « Ben riflettendo alle conseguenze deleterie che una Costituzione la quale, abbandonando la pietra angolare della concezione cristiana della vita, tentasse di fondarsi sull’agnosticismo morale e religioso, porterebbe in seno alla Società, e nella sua labile storia, ogni Cattolico comprenderà facilmente come ora la questione che, a preferenza di ogni altra, deve attirare la sua attenzione e spronare la sua attività consiste nell’assicurare alla generazione presente ed alle future il bene di una Legge fondamentale dello Stato che non si opponga a sani principi religiosi, e morali, ma ne tragga piuttosto vigorosa ispirazione, e ne proclami e ne persegua sapientemente le finalità. Giovi a questo riguardo ricordare che non sempre la novità delle Leggi è fonte di salute per il Popolo: sovente invece la precipitosa ricerca di radicali innovazioni è indice di oblio della propria dignità e di facile resa ad estranei influssi e non a meditate idee. SAPPIANO DUNQUE I CATTOLICI ITALIANI CHE IL RIMANERE FEDELI ALLE MIGLIORI E PROVATE TRADIZIONI SPIRITUALI E GIURIDICHE NON VUOL DIRE ESSERE OSTILI ALLE TRASFORMAZIONI SOCIALI CHE MEGLIO RISPONDANO AL BENE COMUNE: e dicano alto al loro grande ed infelice Paese che il patto onde esso vuol essere condotto ad unità e stabilità, non può cementarsi né con odî né con egoismi di classi, sì bene con la mutua e cristiana carità che tutti i cittadini affratelli in reciproco aiuto, collaborazione e rispetto».
fonte: https://www.radiospada.org/2014/08/degasperi-un-alfiere-dellanticristianesimo-prima-parte/?fbclid=IwY2xjawMRBJ1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETB4VnZBYkVBdTJkNHhqUEZrAR5AkwzkBQyFEWKlWtJtbwfMrSGIRnEP6U1OA-zz9yZtHUkxwZ3K9GfwMzHlGQ_aem_zTqd6F_fZBpOlABCqk8NHg