Proscritti, orfani di una nazione scomparsa. Rompiamo l'accerchiamento psicologico di chi ci vorrebbe nel ghetto, nella fogna delle opinioni irricevibili. Navighiamo a vista nelle rovine elettroniche del nostro tempo per preparare il terreno culturale della riscossa ideale.
martedì 14 ottobre 2014
MANI DI FANGO
domenica 3 agosto 2014
LA STRANA STORIA DELLA SOCIALIZZAZIONE
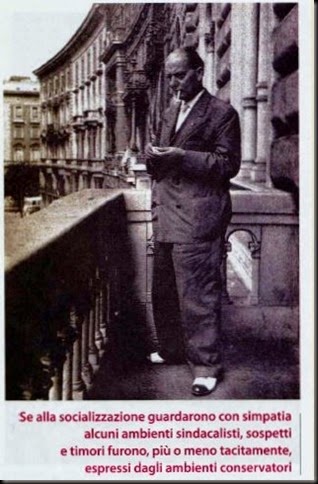 |
| Angelo Tarchi (1897-1974) Ministro dell'Economia Corporativa |
Con il decreto del 12 febbraio 1944, la Repubblica Sociale Italiana si proponeva di <stare con il popolo, superando quell'andare verso il popolo> che era stato tipico del Regime. Se alla socializzazione guardarono con simpatia alcuni ambienti sindacalisti, sospetti e timori circa i suoi esiti e la sua rapida applicazione furono, più o meno tacitamente espressi, dagli ambienti conservatori. Ciò spiega il ritardo con cui il decreto fu pubblicato sulla <<Gazzetta Ufficiale>, in contemporanea con il decreto che
ne fissava al 3o giugno l’entrata in vigore. Un terzo decreto, datato 3o agosto 1944, dettò norme per una sua più sollecita attuazione. Malgrado il ro luglio e il 13 settembre fosse stata disposta la socializzazione delle aziende dell'IRI e del settore dei giornali e dell'editoria, i primi effettivi cambiamenti si ebbero solo alla fine del ry44 Una settimana dopo l'ultimo bagno di folla ricevuto dal Duce a Milano e il discorso al Lirico, fu pubblicato il 22 dicembre il decreto con le norme attuative e integrative della socializzazione. Il documento, accogliendo le ragioni dei sindacalisti,
attribuiva maggiori poteri al sindacato, cui spettava il compito di soprintendere alle elezioni interne alle aziende; ai consigli di gestione, che potevano nominare il capo dell'impresa, convocare riunioni del consiglio e presiederle in mancanza del capo dell'impresa; ai rappresentanti dei lavoratori, nell'assemblea, non licenziabili né trasferibili in dipendenza dell'attività svolta nell’esercizio della loro carica, Il r9 gennaio 1945 fu istituito il ministero del Lavoro, retto da Giuseppe Spinelli, che prevedeva una Direzione generale per la socializzazione e assorbiva i poteri del ministero dell'Economia corporativa. Soppresso quest'ultimo, Tarchi passò a reggere il nuovo ministero della Produzione industriale. La Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1945 pubblicò il decreto sull’ordinamento della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti, creata il 20 dicembre 1943. Questa doveva riunire le precedenti confederazioni per superare lo sbloccamento del 1928, mentre a fine dicembre del 1944 si era disposta la liquidazione delle confederazioni padronali.
 Dall'inizio dell'ultimo anno di guerra presso il ministero del Lavoro si assistette a una frenetica attività socializzatrice. Le aziende socializzate sarebbero state 76, con rz9 mila dipendenti e 4.fl9 milioni di lire di capitale. Ancora oggi poco si conosce in merito all'effettiva applicazione dei provvedimenti. Ciononostante è possibile affermare, perlomeno nel caso della FIAT della maggioranza delle imprese socializzate, che la fine del Fascismo giunse prima che le misure disposte per decreto dalle autorità repubblicane avessero un concreto impatto sulle realtà aziendali sul piano della predisposizione di statuti e decreti relativi alle singole imprese. Il progetto di socializzazione della RSI naufragò per vari motivi, oltre che per il momento tardivo della sua messa in atto: determinanti furono le divergenze interne allo Stato fascista repubblicano riguardo a misure che rimasero inerti per molti mesi, in una situazione definita <rivoluzionaria>, ma tale più sul piano delle parole che su quello dei fatti. Decisive furono sia l’ostilità dei tedeschi, preoccupati per le possibili conseguenze nel campo della produzione bellica, e desiderosi di appropriarsi di macchine e materiali dell'industria italiana, sia la contrarietà degli esponenti di quest’ultima, i quali boicottarono, anche grazie ai legami con la grande industria germanica, i provvedimenti che pure fecero finta di approvare, cercando di rinviarli quanto più possibile. Se molti operai disertarono le elezioni delle Commissioni interne, è anche vero che a esse guardarono con interesse e per vari motivi certi ambienti della sinistra antifascista. Alcuni esponenti di quest'ultima in esilio all'estero erano rientrati in Italia, convinti che, liberato dai vincoli reazionari imposti dal regime, il Fascismo potesse realizzare finalmente le sue pagine di politica sociale più avanzata. Era il momento della <politica dei ponti> che vedeva alcuni antifascisti guardare con interesse alla repubblica del Duce; potremmo, fra i tanti, citare a proposito i fratelli Bergamo, rientrati dalla Francia in nome dei vecchi ideali sociali, repubblicani e antiborghesi. Alcuni rivoluzionari di sinistra ritennero che la politica delle <mine sociali> potesse qualificare agli occhi dei lavoratori l’ultimo Fascismo. A Terni nell'ultimo periodo della RSI, si assistette all'elezione delle commissioni di fabbrica, da cui nel dopoguerra sarebbero sorti i consigli di gestione, presi a modello dal più importante e rappresentativo sindacato italiano, la CGIL. Nella
Dall'inizio dell'ultimo anno di guerra presso il ministero del Lavoro si assistette a una frenetica attività socializzatrice. Le aziende socializzate sarebbero state 76, con rz9 mila dipendenti e 4.fl9 milioni di lire di capitale. Ancora oggi poco si conosce in merito all'effettiva applicazione dei provvedimenti. Ciononostante è possibile affermare, perlomeno nel caso della FIAT della maggioranza delle imprese socializzate, che la fine del Fascismo giunse prima che le misure disposte per decreto dalle autorità repubblicane avessero un concreto impatto sulle realtà aziendali sul piano della predisposizione di statuti e decreti relativi alle singole imprese. Il progetto di socializzazione della RSI naufragò per vari motivi, oltre che per il momento tardivo della sua messa in atto: determinanti furono le divergenze interne allo Stato fascista repubblicano riguardo a misure che rimasero inerti per molti mesi, in una situazione definita <rivoluzionaria>, ma tale più sul piano delle parole che su quello dei fatti. Decisive furono sia l’ostilità dei tedeschi, preoccupati per le possibili conseguenze nel campo della produzione bellica, e desiderosi di appropriarsi di macchine e materiali dell'industria italiana, sia la contrarietà degli esponenti di quest’ultima, i quali boicottarono, anche grazie ai legami con la grande industria germanica, i provvedimenti che pure fecero finta di approvare, cercando di rinviarli quanto più possibile. Se molti operai disertarono le elezioni delle Commissioni interne, è anche vero che a esse guardarono con interesse e per vari motivi certi ambienti della sinistra antifascista. Alcuni esponenti di quest'ultima in esilio all'estero erano rientrati in Italia, convinti che, liberato dai vincoli reazionari imposti dal regime, il Fascismo potesse realizzare finalmente le sue pagine di politica sociale più avanzata. Era il momento della <politica dei ponti> che vedeva alcuni antifascisti guardare con interesse alla repubblica del Duce; potremmo, fra i tanti, citare a proposito i fratelli Bergamo, rientrati dalla Francia in nome dei vecchi ideali sociali, repubblicani e antiborghesi. Alcuni rivoluzionari di sinistra ritennero che la politica delle <mine sociali> potesse qualificare agli occhi dei lavoratori l’ultimo Fascismo. A Terni nell'ultimo periodo della RSI, si assistette all'elezione delle commissioni di fabbrica, da cui nel dopoguerra sarebbero sorti i consigli di gestione, presi a modello dal più importante e rappresentativo sindacato italiano, la CGIL. Nellacittà umbra il Fascismo volle giocare la carta delle commissioni interne abolite con il patto di Palazzo Vidoni (con il quale il 2 ottobre 1925 1l Regime aveva avocato a sé la rappresentanza sindacale con il consenso di Confindustria, che da quel momento avrebbe avuto come referenti sindacali le Corporazioni fasciste e non più i liberi sindacati) e in questo capitolo della storia del sindacalismo entrarono in gioco anche i partiti di estrema sinistra. In principio la loro posizione ufficiale fu di <combattere in tutte le forme i sindacati fascisti e le loro organizzazioni anche facendo dimettere dalle commissioni interne legali i propri iscritti che esercitassero ancora tali funzioni>. Tuttavia questo non fu possibile per la mancanza in Umbria di organizzazione sistematica dell'antifascismo, come attesta la documentazione conservata nell'archivio del PCI. il fronte antifascista in questa regione, debole anche per le diffidenze esistenti al suo interno, accettò quindi che, accanto ai fascisti, e con il consenso delle autorità repubblicane, fossero eletti suoi elementi, comunisti, socialisti e anarchici. Questa scelta finora occultata, perché imbarazzante, può essere spiegata con la disorganizzazione dei comunisti, con lo scarso numero dei componenti le loro cellule nelle acciaierie, con la diffidenza esistente tra le forze di sinistra, con la volontà - comune anche ai fascisti - di opporsi al prelevamento operato dai tedeschi dei macchinari e dei materiali industriali. Ci furono, soprattutto tra i comunisti, iniziali opposizioni e titubanze circa la presenza di loro uomini nelle liste dei candidati; poi, però, ai <compagni> occupati negli stabilimenti e nei cantieri giunse dal vertice del PCI la direttiva di nominare e far riconoscere dalla direzione le
 |
| Le Acciaierie di Terni nel 1930 |
essi ne avrebbero rivendicato il diritto: <Noi siamo contro oggi alle commissioni interne fasciste e ne boicottiamo con tutti i mezzi le elezioni, ma è evidente che domani, a liberazione avvenuta, procederemo immediatamente alla nomina delle commissioni interne operaie...u. Un implicito riconoscimento del fatto che anche l'odiata dittatura aveva compiuto qualcosa di buono per i lavoratori. Negli stabilimenti siderurgici della <Terni>, accanto ai sindacalisti Maceo Carloni e Faliero
Rocchiccioli, firmatari nel r94o del contratto dei metalmeccanici e ad altri fascisti come l'operaio Bruno Marini e l'impiegato Alvaro Garzuglia, furono eletti il socialista
Giuseppe Scalzone per la categoria impiegati; per la categoria operai: Ettore Secci, già socialista, poi sindacalista fascista, quindi comunista; l’ex confinato socialista Umberto Bisci; l’anarchico Gioacchino Orientali e Luigi Campagna, futuro assessore comunista al Comune di Terni: tutti noti per il loro passato sovversivo. L'esperimento ternano fu attuato nonostante le disposizioni impartite, qualche giorno dopo, 717 marzo, dal commissario nazionale del lavoro, per impedire che fossero chiamati a rappresentare le maestranze lavoratori non iscritti. Il decreto proibiva a chiunque di assumere per qualsiasi motivo la rappresentanza di maestranze industriali, la cui tutela, è, a norma delle vigenti leggi, di esclusiva competenza delle organizzazioni
 |
| Manifesto Antifascista che bolla come truffa la socializzazione |
andato del tutto perduto, passando parzialmente in eredità ai partiti antifascisti. Preoccupato di fare salvo il principio della partecipazione operaia alla gestione delle aziende, pur abrogando la regolamentazione sociale fascista, il Comitato di liberazione nazionale per l'alta Italia, fin dal 17 aprile 1945 predispose un decreto che utilizzava lo schema tecnico dei consigli di gestione creati dalla nazionalizzazione di Mussolini. Il CLNAI, abrogando la legislazione della RSI in materia di socializzazione delle imprese, dichiaro decaduti gli organi da questa creati, sancendo il principio della partecipazione agli utili e alla gestione delle aziende attraverso <nuovi e democratici> consigli di gestione; condannò gli <obiettivi antinazionali> della socializzazione con cui il Fascismo aveva tentato di <aggiogare le masse lavoratrici dell'Italia occupata al servizio e alla collaborazione con l’invasore tedesco>; riconobbe <l'alta sensibilità politica e nazionale delle maestranze dell'Italia occupata che, astenendosi in massa da ogni partecipazione alle elezioni dei rappresentanti nei consigli di gestione, hanno manifestato la loro chiara comprensione del carattere antinazionale e demagogico della pretesa " socializzazione" fascista>.
Se il più importante sindacato, la comunista CGIL, il 23 settembre 1945 approvò un documento in cui si parlava di <diretta partecipazione delle maestranze alla gestione
dell'azienda, realizzabile ad opera dei consigli di gestione>, l'atteggiamento ostile degli imprenditori non permise di andare oltre le buone intenzioni e un progetto di legge Morandi-D’Aragona sui consigli di gestione non fu mai approvato, e la materia continuò a essere disciplinata attraverso accordi aziendali da cui la gestione vera e propria era esclusa. Nel novembre del ry47 fu decisa l'istituzione di una commissione
speciale con il compito di elaborare la <Carta> dei consigli di gestione, ma non fu nemmeno eletta. Laddove istituiti, i consigli sopravvissero fino all'inizio degli anni Cinquanta, solo come semplici organismi fiancheggiatori dei sindacati. Fu questo il caso delle acciaierie ternane dove già alla fine del ry44 era stato stipulato un patto
per la partecipazione diretta di operai, tecnici e impiegati alla gestione dell'impresa. Il z9 gennaio ry45, 1l leader sindacale comunista Giuseppe Di Vittorio, parlando di questo patto al congresso della CGIL, affermo che esso apriva ai lavoratori nuovi orizzonti, dal momento che affermava il principio che il progresso produttivo non si
svolge come qualcosa di estraneo ai lavoratori, non è qualcosa che interessa esclusivamente il capitalista ed è in funzione soltanto del profitto, ma è qualche cosa cui è legato l’interesse della società, l’interesse del Paese, per cui i lavoratori stessi debbono partecipare alla gestione delle aziende>. Il patto di Terni divento, per il sindacato confederale del dopoguerra, il modello da imitare e da applicare alle altre
imprese italiane. Era tuttavia destinato a esaurire la propria carica innovativa per il sopraggiungere di circostanze sfavorevoli legate alla crisi della produzione, alla disoccupazione, alla ricostruzione del secondo dopoguerra.
Nell’Assemblea costituente Tito Oro Nobili, deputato socialista di Terni, ricordò l’esperienza dei consigli di gestione nella sua città, proponendo un emendamento al 43" articolo della Costituzione e chiedendo di inserire, laddove si parlava del diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione delle aziende, <per mezzo dei propri rappresentanti in un comitato paritetico con i rappresentanti dell'impresa>. Poi però lo ritiro dichiarando di votare il testo della Commissione per non causare divisioni. Con la vittoria alleata e l’ingresso dell'Italia nell'area sotto l'egemonia statunitense era ormai prevalsa una linea politica neoliberista con cui si torno alla situazione che il ventennio non era riuscito a modificare, alla divisione tra capitale e lavoro, tra economia ed etica. Il sindacato fu ricondotto nell'ambito dell'associazionismo <libero e volontario>, con funzioni di rivendicazione e contestazione nei confronti sia della classe imprenditoriale sia dello Stato. Il sogno di una confederazione unitaria del sindacalismo italiano era destinato a non realizzarsi mai più.
Stefano Fabei
Nota: articolo estrapolato dalla rivista Storia in rete, n.105-106, Lugio-Agosto 2014
lunedì 16 giugno 2014
Delitto Matteotti: ecco il vero retroscena
 Con il noto discorso del 3 gennaio 1925 Benito Mussolini si era assunto la responsabilità del delitto Matteotti e, osserva Giorgio Galli, «questa assunzione di responsabilità fu, da allora, interpretata come un’ammissione di colpevolezza per l’assassinio di Matteotti». Attorno a questa interpretazione ruotano ancora oggi le principali ipotesi storiografiche tutte incentrate sulla vendetta politica e sul complotto affaristico ma tutte decontestualizzate dalla situazione politica del tempo. Novant’anni dopo è però possibile ricomprendere il delitto Matteotti calando la drammatica vicenda nel contesto storico e politico in cui essa maturò a cominciare dalle famose elezioni del 1924.
Con il noto discorso del 3 gennaio 1925 Benito Mussolini si era assunto la responsabilità del delitto Matteotti e, osserva Giorgio Galli, «questa assunzione di responsabilità fu, da allora, interpretata come un’ammissione di colpevolezza per l’assassinio di Matteotti». Attorno a questa interpretazione ruotano ancora oggi le principali ipotesi storiografiche tutte incentrate sulla vendetta politica e sul complotto affaristico ma tutte decontestualizzate dalla situazione politica del tempo. Novant’anni dopo è però possibile ricomprendere il delitto Matteotti calando la drammatica vicenda nel contesto storico e politico in cui essa maturò a cominciare dalle famose elezioni del 1924.  Matteotti aveva vinto a sinistra, Mussolini aveva trionfato a destra; ma entrambi avevano adesso un problema. Mussolini intendeva sganciarsi dalla destra economica; Matteotti intendeva bloccare la concorrenza a sinistra dei comunisti che, peraltro, insieme ai massimalisti di Giacinto Menotti Serrati potevano contare una forza parlamentare che raddoppiava quella dei socialisti unitari. Il governo Mussolini, con l'avallo di economisti come Luigi Einaudi, stava orientando la sua politica economica verso una richiesta di consistenti prestiti agli Stati Uniti d’America. Mussolini intendeva trattare prestiti a lungo termine con finanziamenti erogati direttamente al governo o alle aziende senza il tramite delle banche, al fine di ricondurre l'economia nazionale al controllo politico sottraendola così al potere bancario. Giuseppe Toepliz, amministratore delegato della potente Banca Commerciale Italiana, insieme agli industriali gravitanti nella sua orbita e interessati agli appalti dello Stato, erano invece decisamente contrari che i prestiti fossero gestiti direttamente dal governo. Nel governo, il sottosegretario al ministero degli Interni Aldo Finzi, genero del potente banchiere romano Clementi e legato a Toeplitz, tutelava gli interessi della filiera bancario-industriale. Per Mussolini, dunque, sganciarsi dalla destra economica significava liberarsi dall'opposizione del sistema bancario alla sua politica economica, ma per fare questo era necessario spostare a sinistra l'asse del governo.
Matteotti aveva vinto a sinistra, Mussolini aveva trionfato a destra; ma entrambi avevano adesso un problema. Mussolini intendeva sganciarsi dalla destra economica; Matteotti intendeva bloccare la concorrenza a sinistra dei comunisti che, peraltro, insieme ai massimalisti di Giacinto Menotti Serrati potevano contare una forza parlamentare che raddoppiava quella dei socialisti unitari. Il governo Mussolini, con l'avallo di economisti come Luigi Einaudi, stava orientando la sua politica economica verso una richiesta di consistenti prestiti agli Stati Uniti d’America. Mussolini intendeva trattare prestiti a lungo termine con finanziamenti erogati direttamente al governo o alle aziende senza il tramite delle banche, al fine di ricondurre l'economia nazionale al controllo politico sottraendola così al potere bancario. Giuseppe Toepliz, amministratore delegato della potente Banca Commerciale Italiana, insieme agli industriali gravitanti nella sua orbita e interessati agli appalti dello Stato, erano invece decisamente contrari che i prestiti fossero gestiti direttamente dal governo. Nel governo, il sottosegretario al ministero degli Interni Aldo Finzi, genero del potente banchiere romano Clementi e legato a Toeplitz, tutelava gli interessi della filiera bancario-industriale. Per Mussolini, dunque, sganciarsi dalla destra economica significava liberarsi dall'opposizione del sistema bancario alla sua politica economica, ma per fare questo era necessario spostare a sinistra l'asse del governo."non si può rimanere sempre estranei; qualche cosa, bene o male, bisogna dire o fare, una collaborazione positiva o negativa deve esserci (...) E' un quesito che pongo alla vostra coscienza; voi lo risolverete; non tocca a me risolverlo".
Nel 1924, però, il quadro politico che faceva da sfondo era cambiato rispetto al t9zz. Mussolini adesso era presidente del Consiglio con una maggioranza ampia e che, grazie al sistema maggioritario, si estendeva ben oltre i confini del suo partito.
Alla Camera e al Senato c'era un’opposizione costituzionale che sovente collaborava con il governo. Matteotti, in quanto segretario del maggior partito della sinistra, era il nuovo Leader della minoranza. Matteotti però, avverte Mimmo Franzinelli, adesso era anche un uomo solo: <segretario di un partito i cui dirigenti propendono - tranne poche eccezioni - per una linea di compromesso>; una condizione rilevata anche da Mauro Canali il quale ha osservato che l'avversione alla collaborazione (<aveva finito per rendere politicamente precaria la sua carica alla segreteria del partito, perché gli aveva inimicato ampi settori di esso, urtando personaggi, come gli organizzatori sindacali, tutti collaborazionisti, che godevano d un indiscusso potere>. Lo stato d'animo in cui si trovava il deputato socialista in quel frangente, mai tenuto in considerazione dalla storiografia, non può non avere influito nelle sue riflessioni sulla situazione politica personale e complessiva. E' possibile che un uomo politico come Matteotti, nelle condizioni anche intime in cui si trovava dentro e fuori il suo partito, non abbia tenuto conto di tutte le possibili soluzioni tese a superare il suo isolamento e a definire I 'assetto politico italiano compreso la scelta della collaborazione, nel 1924 ancora circolante all'interno del suo partito e del sindacalismo confederale?
 Il terzo elemento riguarda la natura del delitto e si ricava dalla trama stessa dell'intera vicenda così com'è stata ricostruita dagli atti processuali e dalla storiografia: il delitto fu politico, ispirato dalla vendetta e dettato dall'esigenza di bloccare la denuncia di un colossale scandalo affaristico che coinvolgeva una parte del mondo politico e di quello finanziario. E' pero necessario riesaminare la natura del crimine da una prospettiva diversa da quella in cui fin qui è stata osservata. Il delitto fu politico ma non va collocato nell'ambito del conflitto tra Fascismo e Antifascismo bensì nel più ampio contesto della lotta combattuta in quel momento tra quelle forze politiche ed economiche che auspicavano un radicale mutamento della scena politica nazionale, e quelle che invece intendevano lasciare immutato lo scenario italiano; e questi due schieramenti erano trasversali al Fascismo e all’Antifascismo. Il delitto fu ispirato dalla vendetta ma non del fascista Mussolini contro l'antifascista Matteotti bensì dalla vendetta dei gruppi fascisti contrari alla svolta, contro lo stesso Mussolini che quella svolta intendeva praticare. Erano gli stessi gruppi che nel 1922 avevano sequestrato il repubblicano Torquato Nanni, amico di Mussolini e di autorevoli esponenti socialisti, per eliminare, spiega De Felice, <un tramite tra Mussolini ed i riformisti> nello stesso momento in cui erano in corso le trattative per una collaborazione dei socialisti con il governo nato dalla marcia su Roma. Del resto, se nel caso della morte di Piero Gobetti per esempio, , esiste una prova documentale della responsabilità di Mussolini, che consiste nel telegramma da questo inviato al prefetto di Torino per rendere <impossibile la vita> all'intellettuale liberale, nel caso di Matteotti non esiste alcuna prova concreta né di un eventuale ordine scritto né di un eventuale ordine a voce. Le frasi incriminate attribuite a Mussolini dagli atti processuali e dalla storiografia provengono dai memoriali di alcuni imputati ma i memoriali, come insegnava Marc Bloch, non costituiscono una fonte storica attendibile.
Il terzo elemento riguarda la natura del delitto e si ricava dalla trama stessa dell'intera vicenda così com'è stata ricostruita dagli atti processuali e dalla storiografia: il delitto fu politico, ispirato dalla vendetta e dettato dall'esigenza di bloccare la denuncia di un colossale scandalo affaristico che coinvolgeva una parte del mondo politico e di quello finanziario. E' pero necessario riesaminare la natura del crimine da una prospettiva diversa da quella in cui fin qui è stata osservata. Il delitto fu politico ma non va collocato nell'ambito del conflitto tra Fascismo e Antifascismo bensì nel più ampio contesto della lotta combattuta in quel momento tra quelle forze politiche ed economiche che auspicavano un radicale mutamento della scena politica nazionale, e quelle che invece intendevano lasciare immutato lo scenario italiano; e questi due schieramenti erano trasversali al Fascismo e all’Antifascismo. Il delitto fu ispirato dalla vendetta ma non del fascista Mussolini contro l'antifascista Matteotti bensì dalla vendetta dei gruppi fascisti contrari alla svolta, contro lo stesso Mussolini che quella svolta intendeva praticare. Erano gli stessi gruppi che nel 1922 avevano sequestrato il repubblicano Torquato Nanni, amico di Mussolini e di autorevoli esponenti socialisti, per eliminare, spiega De Felice, <un tramite tra Mussolini ed i riformisti> nello stesso momento in cui erano in corso le trattative per una collaborazione dei socialisti con il governo nato dalla marcia su Roma. Del resto, se nel caso della morte di Piero Gobetti per esempio, , esiste una prova documentale della responsabilità di Mussolini, che consiste nel telegramma da questo inviato al prefetto di Torino per rendere <impossibile la vita> all'intellettuale liberale, nel caso di Matteotti non esiste alcuna prova concreta né di un eventuale ordine scritto né di un eventuale ordine a voce. Le frasi incriminate attribuite a Mussolini dagli atti processuali e dalla storiografia provengono dai memoriali di alcuni imputati ma i memoriali, come insegnava Marc Bloch, non costituiscono una fonte storica attendibile.

Velia rimase in Italia con i figli, non seguì gli antifascisti nell'esilio, e la famiglia Matteotti ricevette segretamente e costantemente da Mussolini un consistente sostegno economico. Mauro Canali ha documentato tali finanziamenti criticando il comportamento della vedova. Quelle somme, però, non servirono a pagare il silenzio di Velia Matteotti com'è stato affermato; dimostrano, semmai, che lei mai ritenne Mussolini responsabile del delitto perché probabilmente sapeva qualcosa che escludeva Mussolini da ogni responsabilità. Posto che questo straordinario <qualcosa» fosse la collaborazione tra Matteotti e Mussolini, e che Mussolini avrebbe ottenuto dalla collaborazione un risultato storico sul piano nazionale e internazionale, cosa sarebbe rimasto a Matteotti? Anch'egli avrebbe conseguito un eccezionale risultato storico, sul piano del Socialismo italiano e mondiale; 1o spiega lo stesso Mussolini quando dichiara, negli anni Trenta, al giornalista Yvonne De Begnac: <noi avevamo interesse a che l'onorevole Matteotti, il più solido fra gli anticomunisti italiani, proseguisse la lotta per l'autonomia e per la riunificazione del Socialismo italiano>. Un governo formato dalla collaborazione tra Matteotti e Mussolini e nato dalla questione morale, mentre I’Italia era in sintonia con l'Unione Sovietica così come con la Gran Bretagna laburista, e mentre in Francia il Socialismo vinceva le elezioni e in Belgio si apprestava a vincerle, avrebbe consentito al Socialismo italiano riunificato di indicare una nuova via a quello europeo e una nuova relazione tra il Socialismo occidentale quello orientale della Russia. Matteotti sarebbe stato l'artefice del rinnovamento del Socialismo internazionale e colui che avrebbe costretto il Fascismo italiano a una svolta a sinistra mentre nascevano in Europa altri movimenti ispirati al Fascismo. Davvero, dunque, la collaborazione con i socialisti, come sosteneva Mussolini, avrebbe determinato una svolta storica nella politica italiana e nella politica internazionale.
Articolo scannerizzato dalla rivista “Storia in Rete”, n°104, del mese di Giugno, 2014.
lunedì 21 maggio 2012
La FINANZA della R.S.I.
Premessa
domenica 21 febbraio 2010
Lucciole per lanterne
domenica, 21 febbraio 2010
"Italiani popolo di santi, poeti e di navigatori..."
B.M.
 Mussolini, in un discorso del 1935, all'inizio della conquista dell'Etiopia, parlando del popolo italiano, fece questa solenne affermazione. Oggi, dopo oltre dieci lustri, il detto andrebbe sicuramente aggiornato. E dire che esistono individui che osano accostare la figura immacolata del Duce, a quella dell'attuale capo del Governo. Una bestemmia vera e propria, che non conosce limiti alla decenza. Ora che la cloaca è stata nuovamente scoperchiata, il fetore aleggia su tutto lo stivale italico, una seria analisi si impone ad ogni onesto italiano (degli Italyoti me ne frego!!). La prima cosa che verrebbe da dire è questa: "Tangentopoli non è servita a nulla". In questa affermazione c'è sicuramente del vero poiché in quella operazione (scattata sicuramente in ritardo e paradossalmente ad orologeria) venne escluso (o quasi) il più grande partito d'opposizione: il P.C.I. Negli anni successivi, Berlusconi ha fatto passare l'idea che le leggi andavano interpretate, la costituzione rivista e che la corruzione fosse inevitabile. Sulla Costituzione sono ancora più drastico, visto che essa ha visto la luce in un periodo storico dove l'obiettività non albergava più a Roma...Non è esattamente un film di cattivo gusto, ma quasi...E' un documentario della storia italiana, fatta d'intrallazzi, di poltrone, di corruzione e malversazioni. Prima, per molto di meno, si rischiava grosso. Ora, visto che il puzzo è diventato insopportabile (non a caso il MSI fece la sua campagna elettorale dopo mani pulite distribuendo "saponette"), si cerca di correre ai ripari. In realtà solo gli ingenui possono credere alla favoletta delle pene più severe per i corrotti. La Corte dei Conti ha quantificato l'andazzo della corruzione con numeri da capogiro: ogni anno ci sarebbe stato un aumento esponenziale del fenomeno. Il guaio è che finanche due Giudici della Corte sono indagati, oltre ad un giudice Costituzionale e ad un Magistrato della Procura romana. Inoltre se prima si rubava per i partiti adesso, a causa di un individualismo esasperato, si ruba per proprio conto. Il guaio è che non esiste alcun freno morale a tale andazzo. Chi non segue la scia è un pirla, un buono a nulla. Ecco la triste verità! Mussolini tentò di ridare dignità al Popolo italiano, senza perseguire politiche di interesse personale. Ecco la verità. Allora lo Stato era proprietario della moneta; adesso nemmeno l'Europa (altro ente creato ad hoc dalle banche) lo è!. E chi fa indebiti paragoni fra il Duce, Benito Mussolini (Che Dio lo abbia in Gloria!) e Berlusconi scambia lucciole per lanterne!!
Mussolini, in un discorso del 1935, all'inizio della conquista dell'Etiopia, parlando del popolo italiano, fece questa solenne affermazione. Oggi, dopo oltre dieci lustri, il detto andrebbe sicuramente aggiornato. E dire che esistono individui che osano accostare la figura immacolata del Duce, a quella dell'attuale capo del Governo. Una bestemmia vera e propria, che non conosce limiti alla decenza. Ora che la cloaca è stata nuovamente scoperchiata, il fetore aleggia su tutto lo stivale italico, una seria analisi si impone ad ogni onesto italiano (degli Italyoti me ne frego!!). La prima cosa che verrebbe da dire è questa: "Tangentopoli non è servita a nulla". In questa affermazione c'è sicuramente del vero poiché in quella operazione (scattata sicuramente in ritardo e paradossalmente ad orologeria) venne escluso (o quasi) il più grande partito d'opposizione: il P.C.I. Negli anni successivi, Berlusconi ha fatto passare l'idea che le leggi andavano interpretate, la costituzione rivista e che la corruzione fosse inevitabile. Sulla Costituzione sono ancora più drastico, visto che essa ha visto la luce in un periodo storico dove l'obiettività non albergava più a Roma...Non è esattamente un film di cattivo gusto, ma quasi...E' un documentario della storia italiana, fatta d'intrallazzi, di poltrone, di corruzione e malversazioni. Prima, per molto di meno, si rischiava grosso. Ora, visto che il puzzo è diventato insopportabile (non a caso il MSI fece la sua campagna elettorale dopo mani pulite distribuendo "saponette"), si cerca di correre ai ripari. In realtà solo gli ingenui possono credere alla favoletta delle pene più severe per i corrotti. La Corte dei Conti ha quantificato l'andazzo della corruzione con numeri da capogiro: ogni anno ci sarebbe stato un aumento esponenziale del fenomeno. Il guaio è che finanche due Giudici della Corte sono indagati, oltre ad un giudice Costituzionale e ad un Magistrato della Procura romana. Inoltre se prima si rubava per i partiti adesso, a causa di un individualismo esasperato, si ruba per proprio conto. Il guaio è che non esiste alcun freno morale a tale andazzo. Chi non segue la scia è un pirla, un buono a nulla. Ecco la triste verità! Mussolini tentò di ridare dignità al Popolo italiano, senza perseguire politiche di interesse personale. Ecco la verità. Allora lo Stato era proprietario della moneta; adesso nemmeno l'Europa (altro ente creato ad hoc dalle banche) lo è!. E chi fa indebiti paragoni fra il Duce, Benito Mussolini (Che Dio lo abbia in Gloria!) e Berlusconi scambia lucciole per lanterne!!
© Douglass






